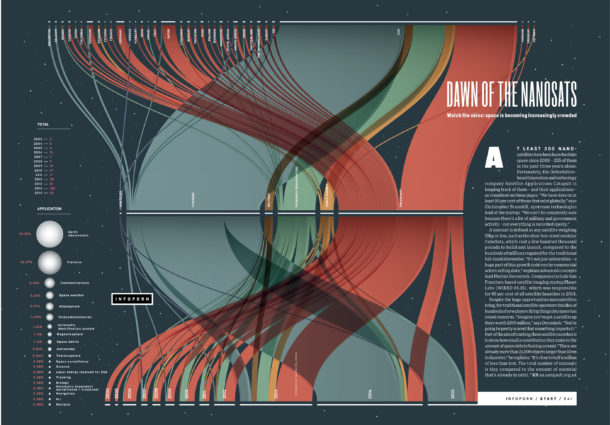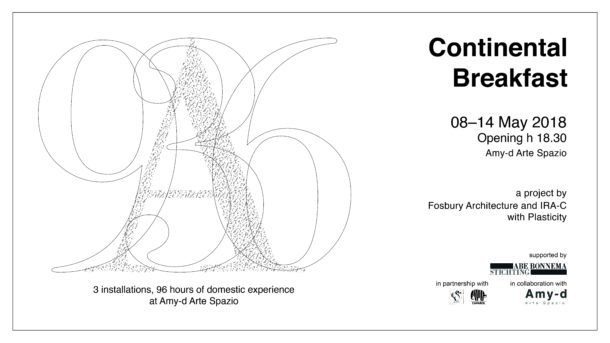Dopo una quindicina di anni di cantieri, dopo aver superato il rischio di vedere irrealizzato Expo, si deve riconoscere che le scelte coraggiose, di ormai una ventina d’anni fa’, e la loro positiva gestione hanno reso possibile lo sviluppo urbanistico alla base della rinascita milanese. Passaggi naturali nella gestione di una grande città, ma nel panorama italiano portare alla conclusione importanti progetti urbanistici e architettonici, dislocati in diversi punti della città come avvenuto a Milano, è un unicum. Indiscutibilmente la città è cambiata e per un architetto il rinascimento milanese, al netto di tutte le implicazioni economiche, sociali e logistiche che esso ha avuto – e avrà – sulla città, è una vera gioia; la stessa gioia che da giovane tifoso e collezionista di figurine mi provocava snocciolare la formazione della Grande Inter, conosciuta a memoria non solo dai propri tifosi, ma anche da quelli avversari, come un orgoglio per l’intero paese. Pei, Pelli, Hadid, Isozaki, Liberskind, Eisenman, OMA, Grafton, Sanaa – a breve… – Herzog e de Meuron, Nouvel – il rischio è quello di dimenticarsi qualcuno – hanno posto la loro firma sul alcuni progetti importanti, affiancando un mondo della progettazione milanese sempre in fermento e impreziosito da alcune interessanti opere di Piuarch, Park Associati, Boeri, Zucchi etc…

Le contrapposizioni tra nuovi volumi e impianto originale della ex distilleria Società Italiana Spiriti.

Una vista della nuova Fondazione Feltrinelli, sullo sfondo il grattacielo di Piazza Gae Aulenti.
A livello puramente architettonico, e forse non solo, Milano è effettivamente diventata una città europea, internazionale, una di quelle città di cui iniziano a vedersi grandi foto sulle riviste patinate di settore e di LifeStyle, sui blog dedicati e forse tra qualche anno sui libri universitari. Il punto da chiarire però è proprio questo: cosa vuol dire e cosa comporta avere i caratteri architettonici di una città internazionale?
La risposta, figlia di una ventina d’anni di globalizzazione, probabilmente è la più banale di tutte: essere uno zoo di grandi firme.
La prima volta che mi sono imbattuto nel concetto di “zoo”, accostato in modo ironico e affettuoso all’architettura è stato durante gli anni universitari, in riferimento ad un progetto molto particolare: il Weissenhof di Stoccaarda.
Nel 1927 la città tedesca è stata il palcoscenico del momento più alto dello spirito modernista; l’eco di tale iniziativa ha segnato l’architettura dei vent’anni successivi, tra variazioni sul genere, fedeltà al programma originario e qualche aperitivo in località amene durante i mitici ritrovi del CIAM. Il Weissenhof è stato, sostanzialmente, una vetrina, un’esposizione internazionale delle idee e delle possibili varietà di applicazione dei canoni del Movimento Moderno. Il masterplan del quartiere alle porte di Stoccarda è stato curato da Mies Van der Rohe che ha coinvolto sedici architetti europei nella progettazione della propria “abitazione modernista”. Del roster di Mies facevano parte, tra gli altri, Le Corbusier, Mies stesso, Oud, Berhens, Walter Gropius, Hans Scharoun, Bruno Taut, Max Taut. Una “Grande Inter” ante litteram della progettazione di cui facevano parte alcuni dei nomi più importanti dell’architettura nordeuropea di inizio ‘900. La cosa che colpisce, soprattutto se confrontata con lo zoo contemporaneo odierno, è proprio il medesimo intento programmatico, il medesimo linguaggio progettuale e i medesimi esiti architettonici: la fedeltà quasi assoluta ai canoni prestabiliti insomma. Mies impose alcune regole comuni: gli edifici dovevano avere forma parallelepipeda, tetto piano ed essere pitturati con colori chiari. Il risultato sorprendente fu che quasi tutti gli architetti realizzarono edifici completamente bianchi – da cui il nome Weissenhof – che presentavano caratteristiche comuni enunciate in questa occasione da Le Corbusier nei «cinque punti della nuova architettura»: Finestre a nastro, pianta libera, pilotis, tetti piani e facciata libera. Una specie di villaggio arabo, o greco catapultato su una collina tedesca con materiali moderni e soluzioni abitative innovative.
Il significato forte del Weissenhof è proprio l’espressione massima di uno stile comune, posto al di sopra dei singoli nomi dei progettisti; effettivamente per una persona non appassionata di architettura tutti questi edifici possono essere considerati molto simili, con leggere sfumature stilistiche; solo Sharoun tentò, infatti, di uscire dal recinto del Moderno con un edificio che ha già in potenza le caratteristiche compositive delle sue opere più famose degli anni successivi, quelle linee curve che diventeranno il suo marchio, così ben espresse nella Filarmonica di Berlino.
In realtà quello che il Weissenhof vuole esprimere è la proposizione di un prototipo di abitazione a basso costo, riproponibile su larga scala fino a ridisegnare le città del futuro. L’intento dei progettisti è, dunque, quello determinare le città tecnologiche che verranno con un modello di vita e abitazione ben specifico e riconoscibile, anche stilisticamente.
L’intento programmatico dei ragazzi dello zoo di Stoccarda si contrappone fortemente con l’intento personalistico dei progettisti che oggi hanno riqualificato e stanno riqualificando radicalmente Milano. La percezione odierna è che più che un disegno comune dei progettisti e degli amministratori, ci sia la ricerca ossessiva del segno stilistico distintivo. E allora il rischio di Milano è proprio questo, di essere un meraviglioso album Panini ma di non saper – e voler – dettare la linea su un nuovo modo di vivere e abitare la città. La sensazione è quella di essere di fronte ad un momento storico in cui la necessità di cambiamento nello stile di vita delle città sia inevitabile e condiviso in tutto il mondo; le città sono storicamente il motore del cambiamento, l’espressione massima della mutevolezza dei modi di vivere. Ma c’è un ulteriore aspetto che mi sembra interessante: oggi siamo di fronte al ripetersi di un ciclo storico, siamo nell’epoca in cui le città vogliono riaffermare la propria importanza e centralità nello sviluppo della cultura, in cui si pongono nuovamente come attori del progresso. Dopo la nascita degli Stati-nazione, dopo un secolo di scontri e l’esplosione del mondo globalizzato, insomma, mi sembra che le città stiano tornando a riaffermare la propria importanza per le sorti dell’umanità come fu per le Poleis greche o per le Città-Stato medievali. La formazione del network mondiale C40, organizzazione che unisce alcune tra le più importanti città al mondo nella condivisione di problemi e soluzioni di fronte alla crisi ambientale in atto sul nostro pianeta, mi sembra un buon esempio, così come le politiche di New York sui temi civili e sociali, in aperta opposizione alle idee reazionarie di Trump. In questa cornice internazionale sembra mancare a Milano – come in moltre altre città – uno stile univoco e unitario, l’emergere del singolo architetto che rispecchia la società individualistica odierna, rende complessa una metamorfosi su larga scala della città, un cambiamento radicale che è e deve essere, innanzitutto, un progetto urbanistico e architettonico condiviso e prestabilito teoreticamente. La necessità di avere città più sostenibili, più verdi in cui il sistema di trasporto principale non sia quello legato alla propria auto sono tematiche già abbastanza importanti per metterci d’innanzi a una rivoluzione copernicana che non può essere risolta da un unico Bosco Verticale o da una somma di Boschi Verticali, come avverrà in Cina. Credo sia questo il vero problema dell’architettura contemporanea e del Rinascimento architettonico milanese; non tanto la mancanza di un –ismo di riferimento sotto cui sentirsi legittimati, ma piuttosto la mancanza di un programma chiaro e ben definito su come sarà il modo di vivere nelle città tra cento anni.

Rappresentazione dello skyline di New York interpretata dagli stessi progettisti dei propri edifici. Si riconosce al centro Wiliam Van Alen, architetto del Chrysler Building.
Godiamoci allora questo nuovo spirito capitalistico milanese fatto di grattacieli, come nei ’20-’30 americani. Godiamoci queste architetture di grande qualità ma perlopiù private. Godiamoci questi grandi architetti schierati sul palcoscenico come i progettisti americani degli anni ’30 nella famosa rappresentazione dello “Skyline di New York”, ironicamente citata da Koolhaas in “Delirious New York”. Godiamoci questo catalogo di scelte estetiche come se stessimo entrando in un parco a tema, consci, tuttavia, di essere di fronte alla necessità di cambiamenti più grandi.