Emile e Juliette, una coppia di coniugi ormai in pensione, decidono di trasferirsi in campagna per trascorrere in tranquillità e solitudine la loro vecchiaia. La loro nuova abitazione è isolata, immersa nel verde: nessun fastidio, niente traffico o confusione, un’oasi di pace. Ma poco tempo dopo il loro trasferimento, i due ricevono una visita: è Palamède, il loro vicino, ovvero il proprietario dell’unico altro casolare della zona, situato a poca distanza dal loro. Emile e Juliette lo accolgono in casa, come impongono le regole del buon vicinato: Palamède entra, si accomoda in poltrona e non dice una parola per le successive tre ore. Alle domande dei coniugi risponde a monosillabi. L’imbarazzo è palpabile. Trascorse le tre ore, si alza e si congeda come nulla fosse. Questa strana visita è solo la prima di una lunga serie: tutti i giorni, allo stesso orario e per lo stesso lasso di tempo, il vicino “invade” la casa di Emile e Juliette, sempre immerso nel suo mutismo, nella sua ritrosia a formulare pensieri e parole, nel suo rifiuto a sottostare alle regole della conversazione civile. E l’imbarazzo della coppia verso questo personaggio indecifrabile si trasforma pian piano in irritazione, in sgomento, in un sempre più profondo senso di inquietudine, fino quasi all’ossessione e alla follia… Comincia così Le Catilinarie, romanzo della scrittrice belga Amélie Nothomb pubblicato nel 1995 che si fonda su un tema molto particolare, che ha avuto grande fortuna in letteratura ma soprattutto nelle rappresentazioni cinematografiche degli ultimi anni; un tema che si potrebbe definire, quasi ossimoricamente, dell’”intruso legittimo”.
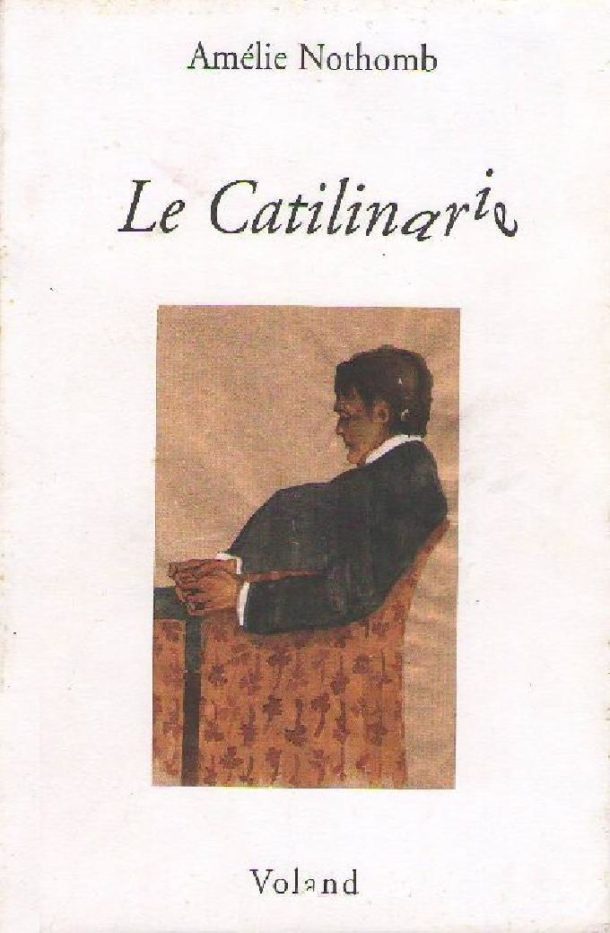
L’intruso (dal latino “intrudere”, “cacciar dentro”, “infilare”) non dovrebbe mai essere legittimo: è colui che, appunto senza averne diritto, con l’inganno o con la forza, si introduce in un luogo in cui non gli sarebbe permesso entrare, che gli è interdetto per legge o che gli è ostile. Ma se consideriamo il Palamède nothombiano, è chiaro che non possiede alcuna di tali caratteristiche: non è un ladro, una spia, un neonazista in un campo profughi, un tifoso della Lazio in curva Sud all’Olimpico. È semplicemente un vicino di casa, a cui viene aperta la porta (deve venir aperta) in virtù delle più basilari regole di cortesia e ospitalità, la xenia sacra presso gli antichi greci. Eppure il suo comportamento, l’insistenza, l’invadenza, il mutismo lo rendono, chiaramente, anche un intruso. Ma un intruso legittimo, appunto, e dunque ancora più destabilizzante, fonte di inquietudine in quanto non immediatamente riconoscibile e definibile: un intruso che vive in una zona d’ombra tra l’archetipo positivo dell’ospite e quello negativo del mostro, e in questa zona può pericolosamente muoversi e agire minando la stabilità e le fondamenta psicofisiche di chi lo ha accolto. Recentemente, fra tutte le arti soprattutto il cinema si è orientato sempre più spesso verso la rappresentazione dell’intrusione legittima, intercettando un diffuso clima politico (il dibattito mondiale sull’immigrazione non ruota forse ai concetti di estraneità, intrusione e legittimità?) e appropriandosi esteticamente della sua carica inquietante e perturbante. Nel cinema contemporaneo, un capostipite in questo senso è un film che è già un cult, Funny Games di Michael Haneke (1997 e poi auto-remake shot-for-shot con produzione americana nel 2007). Haneke sfrutta appieno le potenzialità della situazione narrativa: la visita alla casa dei protagonisti da parte dei due ragazzi, ospiti dei vicini, gentili ed educati (dunque, in un primo momento, rassicuranti e “legittimi”), si trasforma presto in un incubo, un perverso gioco di segregazione e violenza che ricorda da vicino Arancia Meccanica. Lo schema è semplice ma molto efficace: il nemico, l’antagonista si maschera dietro un’apparenza di legittimità, cordialità e rassicurazione; in questo modo riesce a penetrare lo spazio privato dei protagonisti, in cui svela la sua natura di intruso e ha campo libero per le sue azioni, questa volta sì, illegittime: nel caso di Funny Games, una crudele e inarrestabile spirale di violento sadismo “ludico”.

Nel 2017, questo schema ha avuto particolare fortuna, e in diverse occasioni registi di alto livello lo hanno ripreso e declinato personalmente, mettendo in scena l’intrusione legittima per giungere a risultati di volta in volta differenti. Prendiamo ad esempio uno dei film più belli dell’anno, madre! (mother!) di Darren Aronofsky. madre! è un film-mondo, un’immensa e vertiginosa allegoria biblica che non esaurisce però in questa singola interpretazione tutto il suo potenziale simbolico. Il protagonista, Javier Bardem, è lo scrittore-Dio; la sua compagna, Jennifer Lawrence, è allegoria della Madonna ma anche e soprattutto della Terra, tanto quanto la Casa di cui si prende amorevolmente e maniacalmente cura, che è il centro spaziale ma anche tematico del film. Bardem-Dio accoglie, accoglie chiunque, apre le porte della casa-Terra a tutti, a una schiera di persone più simili a fan sfegatati di una rockstar che a fedeli di una religione; accoglie perché Dio ama tutte le sue creature ma anche perché è vanitoso, vuole che tutti lo vedano e lo celebrino, si nutre avidamente di adulazione e devozione. E la Lawrence-Terra non capisce, è sempre più confusa e spaventata, perché questi intrusi (ma legittimamente invitati) aumentano esponenzialmente, si moltiplicano, e in un crescendo di menefreghismo, inciviltà e violenza maltrattano e deturpano la Casa, arrivando infine a distruggerla. Nel complesso intreccio simbolico di Aronofsky, il tema dell’intrusione legittima occupa un posto di primo piano e si carica di valori esistenziali: gli intrusi siamo noi, esseri umani che, “invitati” da Dio sulla Terra, ripaghiamo il favore con l’incuria, la follia, la distruzione (emerge evidentemente anche il discorso ambientalista, molto caro al regista). In madre! lo spettatore si trova così oppresso e schiacciato dalla sensazione di impotenza verso gli atti inconsulti di questi intrusi invadenti: due sconosciuti che si siedono e poi sadicamente “saltellano” sul bancone di un lavandino fissato male, nonostante la padrona della Casa li avesse pregati di non farlo, diventano l’immagine del dolore provato quando qualcuno ferisce con noncuranza ciò che ami, ciò a cui ti sei dedicato con impegno e pazienza. Gli intrusi legittimi di madre! non hanno il minimo rispetto, sono ciechi nella loro follia e conducono il tema alle estreme conseguenze, tra virtuosistici e assurdi assalti di fan del Dio in assetto militare, cannibalismo infantile e, infine, come compimento ultimo, violenza fisica direttamente sulla protagonista. Il volto tumefatto della Lawrence è la concretizzazione estrema del pericolo insito nell’intrusione, e nel profondo violento dell’istinto umano.

Se in madre! il tema dell’intrusione è funzionale alla costruzione di una articolata impalcatura allegorica, ci sono altri film in cui la macchina narrativa messa in moto dall’intruso segue vie più canoniche: è il caso de L’inganno (The beguiled), di Sofia Coppola. Vincitore per la miglior regia a Cannes 2017, remake dell’omonimo film di Don Siegel del 1971, L’inganno è un film non particolarmente riuscito che però, basandosi sull’intrusione, ne mostra compiutamente l’effetto principale: la rottura dell’equilibrio all’interno di una comunità chiusa. Il protagonista, Colin Farrell, è un caporale nordista durante la guerra di Secessione, che viene trovato ferito nel bosco da una studentessa di un collegio femminile in Virginia; seppur contro le regole e potenzialmente pericoloso, la direttrice del collegio (Nicole Kidman), spinta dai dettami della carità cristiana, decide di accoglierlo e di prestargli le cure necessarie. Ciò che determina l’intrusione in questo caso è non tanto lo scontro di schieramenti politici (il nordista rappresenta comunque un nemico), ma lo scontro di genere: l’elemento destabilizzante è l’erotismo; la presenza maschile risveglia la curiosità e la libido tra le abitanti del collegio, e intorno al centro di irradiazione della stanza in cui riposa il caporale ferito si sviluppa un vortice di seduzione, menzogne, sesso e morte. L’intruso de L’inganno non agisce, non ha trame criminali e non compie azioni perturbanti; la sua virilità è sufficiente a sprigionare istinti soffocati: l’intrusione è la bomba che fa esplodere una bolla di repressione e di regole.

Una declinazione ancora diversa del tema è quella che troviamo nell’ultimo lavoro di Roman Polanski, Quello che non so di lei (D’apres une histoire vraie). La protagonista, Delphine (Emmanuelle Seigner), è una scrittrice in crisi creativa che incontra Elle (Eva Green), donna estremamente affascinante e, apparentemente, sua ammiratrice assidua. Elle pian piano, con gentilezza, charme, astuzia e caparbietà, entra sempre più a far parte della vita di Delphine, fino all’eccesso: prima la aiuta, la ascolta, la fa sentire capita; poi si trasferisce da lei, si sostituisce a lei in alcuni incontri pubblici, penetra sempre più a fondo nel suo privato, fino a sopraffarla completamente e a manipolare l’intera sua vita. L’intrusione si compie tramite un lavorio psicologico sottile e corrosivo, in cui l’intruso si trasforma progressivamente da amico a nemico, da angelo a mostro. Eppure, non è così semplice: il film di Polanski indaga, in un continuo gioco di specchi, il rapporto tra realtà e finzione, tra i fatti e le storie, tra ciò che si vede e ciò che si crede di vedere. Più si va avanti nella visione, più si intuisce che forse tutto ciò che accade è solo il prodotto di un’ossessione, e il rapporto tra Delphine ed Elle si gioca tutto nella mente della protagonista: Elle non esiste, è figura della crisi creativa di Delphine ed è insieme il riscatto, è la storia stessa che sta cercando, è una narrazione. Polanski ci mostra che non sempre l’intrusione avviene dall’esterno: la nostra mente e il nostro inconscio possono creare intrusi che abitano in noi (e chi più legittimo di loro, nostre creazioni?), che sono depressione, monomanie, ossessioni, e ci possono incastrare, sedurre e distruggere con il volto affascinante e terribile di una Eva Green.

Peculiare nel nostro discorso è il caso di Elle, film di Paul Verhoeven con protagonista Isabelle Huppert. La narrazione prende avvio da un’intrusione classica, tutt’altro che legittima: un uomo, con il volto coperto da un passamontagna, irrompe con la forza in casa della protagonista Michèle, la aggredisce e la violenta. Ciò che è particolare è che la legittimazione giunge a posteriori: Michèle decide di non denunciare l’aggressione e inizia ad indagare per conto proprio, spinta da un misto di attrazione e desiderio di vendetta. La sessualità di Michèle, forse intrinsecamente connessa a modalità violente a causa di un trauma infantile (il padre aveva compiuto una strage di bambini), risponde in modo contraddittorio allo stupro, e una strana eccitazione ha la meglio sulla paura. Così, una volta individuato il suo aggressore, Michèle inizia con lui un perverso gioco di sesso e violenza: lo rende legittimo, gli apre le porte della sua casa e della sua intimità, non è più intruso ma complice. Ma affinché il gioco funzioni e resti eccitante, le condizioni in cui si deve ripetere sono, in apparenza, quelle dell’intrusione illegittima e forzosa: siamo dunque al rovesciamento della norma, ad un’intrusione sessuale che ottiene la sua legittimazione nel protrarre la finzione di un’intrusione illegittima. Verhoeven, ribaltando la prospettiva, ci ricorda che la sfera sessuale (che è naturalmente, sempre, una sfera di intrusione, in un corpo, in un’intimità) è un dominio a sé, un luogo di finzione in cui i ruoli e le regole possono essere diversi, se non opposti, rispetto a quelli della vita comune.

L’ultimo film dello scorso anno di cui ci occupiamo che metta in scena l’intrusione è probabilmente il più difficile da decifrare, frutto della mente geniale di uno dei più grandi registi contemporanei: Il sacrificio del cervo sacro (The killing of a sacred deer) di Yorgos Lanthimos. Lanthimos, indiscusso caposcuola di quella fucina di capolavori che è la cosiddetta Greek New Wave, da sempre ritrae nei suoi film (Kinetta, Dogtooth, Alps, The Lobster) situazioni in cui gruppi o ambienti (familiari o di comunità) chiusi, ossessivi, isolati dal resto del mondo nel tentativo di creare un mondo a parte non contaminato dal dolore, implodono e crollano su se stessi spesso proprio a causa di un’intrusione dall’esterno. Ma il caso del Cervo sacro è diverso: Lanthimos ha voluto coraggiosamente cambiare rotta e puntare più in alto, recuperando il patrimonio mitologico alla base della sua cultura e tentando una (libera) riscrittura del sacrificio di Ifigenia, in un film che ruota intorno ai concetti di giustizia, colpa ed espiazione. L’intruso, in questo caso, è Martin (Barry Keoghan), un ragazzino che intrattiene un rapporto misterioso con il protagonista, Steven (Colin Farrell), cardiochirurgo e padre di famiglia. Martin trascorre tempo con Steven, viene invitato a casa sua, e la famiglia del protagonista non comprende la reale natura del suo rapporto con questo adolescente. Tale natura viene ad un certo punto svelata: il padre di Martin è morto sotto i ferri di Steven (per una fatalità o per sua negligenza?), quindi il chirurgo ha deciso di prenderlo sotto la sua ala, per aiutarlo ad elaborare il lutto (o per evitare guai giudiziari?). Ma il film a questo punto ha uno scarto, abbandona il campo della logica e del razionale per entrare in quello delle forze mitiche e ancestrali: Martin rivela a Steven che, per riequilibrare la giustizia, dovrà scarificare un membro della sua famiglia; se e finché non lo farà, la moglie e i due figli andranno incontro a un doloroso decadimento fisico in varie fasi che li porterà alla morte. Ecco svelata la vera natura dell’intruso: egli è una forza superiore, un dio o un demone, ed è l’incarnazione di un principio di giustizia da un lato crudele, dall’altro ineccepibile. Martin, con la sua presenza ed il suo corpo, è la concretizzazione del senso di colpa e del dovere di espiazione: è, dunque, di nuovo un intruso legittimo in quanto creato da noi stessi; ma se nel film di Polanski il campo era quello della psiche, qui è quello della morale e dell’etica, di un sistema di regole quasi primordiale, definito dall’uomo ma capace di travalicarlo. L’intruso è la legge, la giustizia morale: Steven non può nulla, non può che convivere con la sua legittimità e piegarsi alle sue richieste. L’intrusione, ancora una volta, è vincente e distruttiva.

Ne Il sacrificio del cervo sacro è ancora più evidente ciò che vale in generale, per tutti i film analizzati: l’intruso è un archetipo, che raccoglie una molteplicità di valori, perlopiù negativi, inquietanti, perturbanti. L’intrusione, che sia concreta o mentale, spaziale o sessuale, determina rottura di equilibri e distruzione; l’intrusione legittima potenzia enormemente, nella sua natura antitetica, il fattore di perturbazione e la potenza del crollo: per questo il suo fascino ha contagiato il cinema degli ultimi anni, e continuerà probabilmente a farlo nei prossimi.














































